Philip Glass

album
in pagina
- Mishima
- The
Photographer
- North
Star
- Music
In Twelve Parts
-
Dance Pieces
- Glassworks
- Music From The
Screen
- Heroes Symphony

Affrontare in maniera esaustiva la figura e l'opera di Philip Glass è
un'impresa a cui abdico: impossibile, in ventimila caratteri circa,
rendere conto di una vicenda che si protrae senza interruzione alcuna
da oltre quarant'anni, sopratutto se si tiene conto che questa vicenda
non ci giunge attraverso il corpo omogeneo di poche e mirate
opere-simbolo, ma al contrario si prodotta in una quantità di lavori,
progetti, manifesti e cambi di rotta letteralmente inverosimili,
sconfinando in una prolificità le cui dimensioni dicono di oltre un
centinaio tra composizioni di vario ordine e grado.
Ancor di più, a essere ingombrante non è solo la produzione
esagerata e qualitativamente instabile: è semmai l'icona Glass a
rendere difficile qualsiasi approcio che non sia forzatamente
parziale, monco, o peggio ancora di parte. Philip Glass è, con tutta
probabilità, il compositore vivente più famoso sulla faccia della
Terra, il suo ruolo investe ambiti diversi, che partono dalla grande
stagione dello sperimentalismo americano (Glass è, assieme a Young,
Riley e Reich, uno dei così detti "quattro grandi" del
minimalismo storico) per arrivare infine, in un percorso tortuoso e
contradditorio, ai grandi numeri delle platee pop. In Mezzo, almeno
un'opera cardine di fine '900, tentativi di legittimazione colta,
commissioni milionarie, colonne sonore, sinfonie, infatuazioni
liriche, ammiccamenti mainstream, e poi ancora il Dalai Lama e David
Bowie, Sol LeWitt e Stephen Hawking, gli orologi Swatch e i Simpson,
per non dire della puntata di South Park in cui Cartman e Stan ballano
il suo "happy man-offensive, non-denominational christmas
play", scatenando una rissa nel pubblico.
Al di là dei meriti musicali insomma, Glass è una presenza di
prim'ordine nel panorama della popular culture USA. E però noi qui di
musica dobbiamo parlare:personalmente, non faccio mistero nel ritenere
il periodo che va dal 1968 al 1976 il cuore e l'apice della sua
carriera, ed è quindi a questo lasso di tempo che gran parte
dell'articolo che segue fa riferimento. Ma ugualmente non si può
sorvolare su almeno un paio di particolari. Il primo, è che di
periodo marginale si tratta, se non altro da un punto di vista
strettamente cronologico-temporale: meno di dieci anni di musica a
fronte di oltre un quarantennio di attività. Il secondo, è che
è proprio sul Glass del dopo '76 che si fonda l'icona popular, con
tutto quello che ne consegue. E anche questi sono ingredienti da
tenere in considerazione, se non si vuole far finta che una
circostanza tanto peculiare (un "compositore di musica
contemporanea" che riesce a conquistare una celebrità
sconosciuta a qualsiasi altro collega del suo tempo) altro non sia che
una nota a margine, o peggio ancora un particolare da rimuovere per
via di qualche insalubre prurito purista.
Philip Glass nasce a Baltimora nel 1937 da una famiglia di origini
ebree-esteuropee. A sei anni studia violino, per poi passare al flauto
e infine, in coincidenza con gli studi al Peabody Conservatory, al
pianoforte. E' un bambino precoce, praticamente un ragazzo prodigio, e
lo è in tutti i campi: a quattordici anni viene ammesso
all'Università di Chicago, dove si laurea in matematica e filosofia.
Parallelamente ha già cominciato a comporee: dopo una breve
infatuazione per Webern, si iscrive alla Juilliard School di New York
e sposa la causa populista, sulla scia di certa Americana alla AAron
Copland. Alla Juilliard, si ritrova come compagno di classe Steve
Reich, ma i due condividono poco e finiranno per frequentarsi solo
molti anni più tardi.
Glass è uno studente modello: diligente e disciplinato, compone
qualcosa come settanta lavori in pochi anni, dando subito prova di una
prolificità che non mancherà di accompagnarlo anche quando questi
lavori verranno rigettati nella pattumiera degli errori di gioventù.
Poco interessato all'effervescente comunità jazz che tanto appassiona
il compagno di classe Reich, il giovane Philip frequenta comunque i
circoli artsy di Downtown Manhattan, e nel 1961 assiste pure a una
performance di La Monte Young (le famigerate composizioni-happening
del periodo Fluxus) nel loft di Yoko Ono. La sua carriera musicale
pare però proseguire sui binari di una rispettabilità di
retroguardia tutta interna all'Accademia: dopo aver studiato con
Darius Milhaud finisce, grazie a una borsa di studio della Ford
Foundation, a insegnare musica nelle scuole pubbliche di Pittsburgh, e
i suoi spartiti continuano a essere pubblicati ed eseguiti con una
certa regolarità.
Il 1964 è l'anno del Theater Of Eternal Music di La Mont Yoyng, di
Terry Riley che scrive
In C,
e di Steve Reich che sperimenta con loop e nastri: il minimalismo è
già nella sua fase matura, ma Glass è evidentemente altrove.
Indeciso sul da farsi, parte per Parigi per studiare (ennesimo
americano di una lunga serie) con Nadia Boulanger: è a Parigi che,
nel 1965, il film-maker Conrad Rooks lo contatta per curare le musiche
di Chappaqua, film psichedelico descritto come un "acid head Epic";
compito di Glass è trascrivere in notazione occidentale i brani per
sitar e tabla prestati alla pellicola da Ravi Shankar e Alla Rakha,
un'esperienza che rappresenterà, per l'allora ventottenne Philip, la
provvidenziale illuminazione.
E' proprio Glass a riportare l'episodio in una descrizione rimasta
celebre: "Ravi mi cantava le musiche, e io tascrivevo passo per
passo. I problemi arrivarono quando sullo spartito tentai di piazzare
le misure alla maniera occidentale: la cosa produceva accenti
indesiderati (...) Ovunque mettessi le barre ('dividendo' quindi la
musica secondo la notazione occidentale), Alla Rakha mi correggeva:
'tutte le note sono uguali', ripeteva. Alla fine, per disperazione,
feci piazza pulita delle barre, cancellandole tutte. E improvvisamente
capii quello che Alla Rakha stava cercando di dirmi: l', davanti ai
miei occhi, aveva preso forma un flusso continuo di pulsazioni
ritmiche". La musica indiana insegna quindi a Glass che
"nella musica occidentale il tempo viene diviso, alla maniera in
cui si prende una certa lunghezza e la si taglia come si taglia un
filone di pane. Nella musica indiana invece, si prendono piccole
unità e le si legano insieme fino a comporre lunghezze sempre
maggiori". La scoperta, che è alla base di tutti i futuri
esperiementi sui moduli, viene dapprima testata sulle musiche di Play,
spettacolo di Samuel Beckett portato in scena, ancora a Parigi, da
quelli che diventeranno i Mabou Mines. La reazione dei musicisti non
si fanno attendere: il brano, due sole note per altrettante linee di
sassofono, li irrita al punto che il compositore, anni dopo, arriverà
a chiedersi "Mi sembrava che la musica fosse così semplice,
così trasparente... cosa c'era da arrabbiarsi?" (Glass però si
dà anche la risposta "Ovviamente, era proprio quello il motivo
per cui si infuriarono").
Nel 1967, dopo aver concluso il biennio di studio con la Boulanger, e
dopo un viaggio in India assieme all'ora moglie JoAnne Akalaitis,
Glass torna quindi a New York dove, appena arrivano, si imbatte in un
concerto dell'ex compagno di studi Steve Reich. La performance, che
comprende tra l'altro un'esecuzione di Piano
Phase, segnerà il
compositore di Baltimora a vita, nonostante un'insistita riluttanza ad
ammetterlo. Glass sottopone a Reich lo spartito dello String Quartet
composto ancora a Parigi dopo l'illuminazione indiana, e in cambio ne
riceve consigli, suggerimenti, e un'esortazione a tentare
"qualcosa di più sistematico". Il rapporto tra i due sarà,
da questo momento in avanti, al tempo stesso collaborativo e
conflittuale. Sulle prime, oltre a inventarsi improbabili imprese
lavorative per sbarcare il lunario e sostenere i rispettivi sforzi
compositivi (una ditta di traslocchi di cui sono i soli titolari;
entrambi vantano inoltre un'onorata carriera come conducenti di
taxi...), condividono anche il medesimo gruppo di musicisti nato
proprio attorno a Reich. Con un nucleo che ruota fondamentalmente
attorno a Jon Gibson, fiatista storico del primo minimalismo, e con
gli stessi Reich e Glass a figurare come strumentisti alle tastiere,
l'ensemble in condivisione durerà poco, fino a quando cioè si
trasformerà de facto nel Philip Glass Ensamble. Lo "scippo"
è solo una tra le ragioni che, nel tempo, porterà la coppia a
consumare una rottura insanabile. Il principale motivo della rivalità
sarà avviamente il mancato riconoscimento, da parte di Glass,
dell'influenza esercitata su di lui dall'uomo di Piano
Phase, al punto che una
composizione come Two Pages
(for Steve Reich) verrà successivamente epurata dalla compromettente
dedica. Nè Reich, nè altri protagonisti della stagione minimalista
perdoneranno a Glass quello che considerano un peccato di presunzione;
non va però dimenticato il malcelato complesso di inferiorità,
stavolta da parte di Glass, nei confronti ancora di Reich, coccolato
dalla critica e considerato unico minimalista degno dello status di
compositore serio, mentre proprio a Glass (da sempre alla ricerca di
riconoscimenti simili) verranno riservati sin dagli esordi giudizi
tutt'altro che lusinghieri.
Influenze altrui o meno, il contributo di Glass alla causa minimalista
è però innegabile: se è vero che la trama di fondo resta quella
repetitive music messa a punto da Riley e perfezionata da Reich, Glass
-anzichè propendere per il flusso di coscienza del primo o per il
meticoloso phasing del secolo- opta per una strada terza. La sua
variante ripetitiva fa perno su un tipico processo addittivo/sottrattivo
della struttura piuttosto semplice: un modulo contenente un numero
scelto di note viene allungato e contratto in strutture cicliche,
cosicchè, per sommi capi, al modulo iniziale viene aggiunta (o
sottratta) una nota; il nuovo modulo così ottenuto viene quindi
ripetuto fino a quando un'altra addizione (o sottrazione) non
interviene ad allungare (o contrarre) la base di partenza, e così
via. Questo processo, che apparentemente condurrebbe a un andamento
elastico del brano, viene però piantato su un ritmo sempre e comunque
costante, fermo, immutabile, e oltretutto senza variazioni nè di
volume nè di intensità (quasi sempre in fortissimo): l'impressione
che se ne ricava è quella di una sorta di falso movimento, di perenne
attesa, di stasi cangiante. Di più, se il tocco di Riley è
solitamente fluido, e quello di Reich misurato, Glass si esprime
attraverso una violenza algida che non ha paragoni nell'allora
ribollente comunità minimale. Quando il suo ensamble punterà tutto
sull'amplificazione e sul suono ruvido degli organi elettrici, ne
scaturirà una musica impetuosa e tesa che sa di furia soffocata a
fatica, "tonale senza traccia di melodie", furiosamente
ritmica pur in totale assenza di percussioni. E sarà, almeno per
qualche anno, veramente grande musicista.
A partire dal 1968, Glass si cimenta in una serie di prove talmente
"minime" da rasentare il pauperismo assoluto: già l'anno
prima, con Strung Out
per violino solo, ha concepito una straniante figura astratta che si
libra fantasmatica nell'aere per un quarto d'ora circa; arriva poi una
dozzina di lavori che costituisce il nucleo del Glass propriamente
minimalista: tra questi, Gradus
(dedicata a Jon Gibson), è una specie di Strung
Out per sassofono; Music
In The Shape Of A Square, di
nuovo con Gibson, insiste su una dimensione concettuale tipica
dell'epoca (dal vivo i due cominciano il brano suonando il flauto
l'uno accanto all'altro, e lentamente si allontanano camminando in
direzione opposta ); How Now
fa pensare al gamelan e si dilunga in una placida distesa di note che
dal nulla appaiono e nel nulla scompaiono; 600
Lines è una sfiancante
rincorsa a incastri per fiati e organo elettrico; In
Again Out Again vede il
pianoforte di Glass e quello di Reich scontrarsi in forme cicliche; 1+1,
per tavolo amplificato,, è una prima rigorosa sistematizzazione del
processo additivo, qui in veste puramente ritmica; e infine la già
citata Two Pages
prevede che una coppia di strumenti (l'incisione storica apparsa in Solo
Music dice organo elettrico
e piano) esegua all'unisono una singola linea musicale per un totale
di 107 moduli.
Tuttu i brani sono pensati per un ensamble che, oltre a Gibson e allo
stesso Glass, negli anni vedrà avvicendarsi personaggi quali Dickie
Landry, Art Murphy e Steve Chambers (già con Reic), fino alle
saltuarie ospitate di Frederic Rzewski, Richard Teitelbaum, e
sopratutto fino all'entrata in pianta stabile della
vocalist-compositrice Joan LaBarbara, che interviene nel momento in
cui Glass decide di aprire le sue composizioni alla voce. E' dunque a
questo ensemble che si deve la straordinaria resa delle opere
appartenenti al biennio 1969-1970: capolavori come Music
In Fifths, Music
In Contrary Motion, Music
In Similar Motion proiettano
Glass nell'olimpo del minimalismo storico e rappresentano un deciso
balzo in avanti rispetto agli esercizi del periodo immediatamente
precedente. Costruiti attorno al suono inesorabile di quello che
diventerà lo strumento d'elezione di Glass, vale a dire l'organo
elettrico amplificato (che può essere in solo, come in Music
In Contrary Motion, oppure
in trio, nella Music In
Simular Motion resa possente
dalla contemporanea presenza di due sassofoni e un flauto), questi
brani suonano radicali, disadorni e incopromissori come nessun altro
esperimento minimalista coevo. Al di là delle diverse tecniche che di
volta in volta vengono esplorate sul tessuto ripetitivo-addittivo
(moti contrari, moti paralleli ecc), a fare la differenza è prima di
tutto il tono spietato, implacabile e scontroso delle esecuzioni. La
precisione inumana degli strumentisti, il ritmo vertiginoso dei brani,
l'ipnosi vagamente paranoide delle partiture, poco hanno in comune con
le solari meditazioni di Riley o con l'eleganza formale di Reich: sono
brani che semmai rimandano -come fu già notato all'epoca- all'energia
tutto sudore e sangue del rock, e la stessa immagine pubblica
dell'ensemble contribuirà ad alimentare il parallelo. Con i loro
capelli lunghi, la loro amplificazione portatile, i loro volumi
assordanti, e senza contare la presenza assidua (benchè forzata: il
minimalismo, nei circoli colti, era ancora considerato eresia) nei
loft piuttosto che nei locali rock, i membri del Philip Glass Ensamble
si faranno la fama di micidiale macchina da guerra per tour de force
dall'intensità inaudita, conquistandosi quindi l'ammirazione del
pubblico giovane e l'inevitabile derisione da parte della comunità
musicale uptown.
La vetta assoluta del periodo resta forse la splendida Music
With Changing Parts, dalla
lunghezza -almeno per gli standard glassiani del 1970- inusitatamente
lunga: da una a due ore di durata. Per la prima volta Glass apre a un
grado, seppur marginale, di improvvisazione (gli esecutori sono liberi
di tenere alcune note scelte, a sottolineare i particolari fenomeni
acustici che si formano a partire dall'intricata trama di contrappunti
e armonie), e gli ormai caratteristici arpeggi della prima parte
lasciano intendere una tensione emotiva sconosciuta agli austeri
quadri "nero su nero" del 1969; la sfuriata motoristica che
interviene a spezzare il languore iniziale, è una sorpresa che
anticipa i movimenti di Music
In Twlve Parts, e in
generale -per dimensioni di architettura- Music
With Changing Parts è un
importante punto di passaggio tra il Glass radicale degli esordi, e
quello massimilista di metà anni '70, giusto a un passo dai trionfi
del periodo Einstein In The
Beach.
Ancora nel 1971, le esecuzioni del Philip Glass Ensamble sono relegate
in spazi e festival dichiaratamente estranei ai circuiti musicali
ufficiali, e appartenenti semmai al mondo dell'arte e dell'avanaguardia
concettuale. L'ingresso ufficiale del minimalismo nel salotto buono
della musica seria risale in effetti al 1973, quando Steve Reich
presenta la sua Four Organs
alla Carnegie Hall di New York, per un concerto-scandalo degno,
secondo i critici, di figurare accanto alla prima della Saga della
Primavera, Glass arriva alla legittimazione mainstream l'anno dopo,
quando finalmente la sua musica viene ospitata in una sala da concerto
anzichè nel solito loft per artisti bohemien: l'opera scelta è la
mastodontica Music In Twelvwe
Parts, scritta a più
riprese nel triennio successivo a Music
With Changing Parts, e dalla
durata complessiva di quasi quattro ore.
Lavoro speso e volentieri magniloquente, tenuto sul filo di un
equilibrio delicatissimo tra gli stridori del periodo radicale e i
progetti-mostre della fase operistica, Music
In Twelve Parts è
probabilmente, se mai ce ne fosse una, la composizione più
rappresentativa del Glass anni '70: lo stesso autore la intende come
una specie di summa di quanto sperimentato a partire dal 1968, e in
effetti, almeno i primi otto movimenti sono una parata, anche
esaltante, di tutti quanti i trucchi, le intuizioni e gli effetti che
da Two Pages
hanno portato a Music With
Changing Parts, pagine di
concitazione assoluta si alternano a distese ipnotiche per fiati e
organo elettrico, i vocalizzi si accavallano tra le intelaiature dei
virtuosismi strumentali, e le tirate a rotta di collo fanno il paio
con una compostezza insolitamente sontuosa, quasi classicheggiante. Le
quattro parti finali indicano soluzioni nuove, meno rigide che in
passato e pericolosamente prossime a un'enfasi che, nell'ultimo
movimento, si prende persino gioco del nemico di sempre, la scuola
seriale: Music In Twelve
Parts è insomma la
celebrazione del minimalismo glassiano e il suo punto di non ritorno,
e che sia iniziata una stagione nuova è a questo punto chiaro.
A indurre Glass verso futuri traguardi ci pensa l'incontro con Robert
Wilson: il compositore lavora per il teatro sin dai tempi dei Mabou
Mines, e il sodalizio con uno tra i più importanti registi
sperimentali in terra d'America non può che risultare fruttuoso,
specie se si considerano le assonanze tra il teatro figurativo
dell'uno e la musica antiteleologica/non-narrativa dell'altro. Non
bastassea, la recente inclinazione di Glass per lavori da durate
ragguardevoli, trova facilmente sponda nelle dimensioni tutt'altro che
"minime" del teatro wilsoniano: il risultato della
collaborazione non può quindi che essere contemporaneamente astratto
e ridondante, allienante e glaciale. Einstein
On The Beach, in quattro
atti, dura in tutto cinque ore: agli spettatori, che quando entrano in
sala trovano l'opera già in corso, è concesso allontanarsi e
ritornare a piacimento. Viene presentato in anteprima al Festival di
Avignone del 1976, e si tradice -nonostante i debiti- in un successo
colossale, tanto di critica che di pubblico. Per molti anni anzi, i
meriti di Einstein On The
Beach vanno oltre il
semplice riscontro artistico: si tratta semmai di una delle opere di
teatro musicale più importanti del secolo '900, e incidentalmente
dell'atto di nascita di una nuova forma operistica tipicamente USA.
Difficile però,vista la peculiarità del teatro di Wilson,
considerare Einstein On The
Beach un'opera in senso
stretto; anche musicalmente, la aprtitura di Glass muove in direzioni
non tanto di un superamento, quanto di un progressivo allargamento dei
tentativi di Music In Twelve
Parts. L'esecuzione è
appannaggio del solito Philip Glass Ensamble, per l'occasione
accompagnato da un piccolo coro, e l'uso della voce è puramente
ornamentale, una sequenza di solfeggi e numeri di tanto in tanto
interrotta da recitati di difficile interpretazione. Nonostante il
ricorrere di alcuni motivi - sia musicali che scenici- Einstein
On The Beach non ha una
trama, nè una storia da raccontare. Chiaramente debitrice del clima
sperimentale dei '70, è per certi versi un'immensa performance, e in
questo sta la sua grandezza e il suo ruolo di rottura all'interno del
canone teatromusicale americano. All'interno della vicenda glassiana
invece, la sua ambogiutà sta nell'essere ancora troppo di confine per
appartenere al periodo mainstream, e troppo ambiziosa per essere
interpretata come naturale sbocco di un percorso cominciato alla fine
dei '60. Per il movimento minimalista infine, Einstein
On The Beach è l'opera che,
assieme alla contemporanea Music
For 18 Musicians di Steve
Reich, chiude un'epoca. Di fatto, nel 1976, a diciotto anni da Trio
For String di La Monte Young
e a dodici dalla In C
di Terry Riley, il minimalismo è già storia: e questo, Glass, lo
capirà benissimo -sebbene alla sua maniera.
Il minimalismo, così come l'intero e complesso mondo dello
sperimentalismo USA, era stato una risposta ai rigidi steccati
dell'Accademia e alla seriosa avanguardia di stampo europeo, percepita
come desueta, integralista e dispotica. Col tempo, quando alcuni dei
suoi protagonisti passeranno all'ufficialità dei grandi auditori,
questa risposta assomiglierà sempre di più a una reazione, quando
non ha una specie di revanscismo tonale neuroromanticcheggiante. Glass
è senza dubbio alla testa del fenomeno: il suo futuro, dopo il
successo di Einstein On The
Beach, sta nelle megalomani
produzioni operistiche, nella fortunata serie di colonne sonore, e
nell'occupazione sistematica di un sentire musicale che negli anni '80
individuerà nei residui del fu minimalismo una delle sue vene più
spendibili, sia dal punto di vista rispettabilità di facciata che
della rimunerativa commerciale. Dopo Einstein
On The Beach, Glass compone
altre due opere che assieme al progetto in comproprietà con Wilson
vanno a completare la sua Portraits
Trilogy: sia Satyagraha
(sulla figura di Gandhi, concepita nel 1979 su richiesta della De
Nederlandse Opera), che Akhnaten
(sul faraone Akhenaton, commissionata dall'Opera di Stato di Stoccarda
nel 1981) sono, al contrario del capolavoro del 1976, opere liriche di
stampo se non classico quantomeno più tradizionale, con tanto di
orchestra al posto dello storico Ensamble, e della tradizionale
irrequetezza del periodo '70 non conservano più traccia. Pur non
mancando passaggi di un certo spessore, nel complesso si tratta di
esperimenti pretenziosi e prolissi, che già testimoniano di una certa
stanchezza compositiva: la ripetizione stavolta è quella di stilemmi
già abbondantemente abusati nel decennio precedente, qui semmai
abbelliti dalle vesti dell'orchestra quando non banalizzano in motivi
di facile presa. Glass però è convinto che sia proprio l'opera il
suo campo privilegiato, e se i critici manterrano nei suoi confronti
la tradizionale severità, l'establishment ringrazierà a più
riprese, tanto i lavori del compositore di Baltimora si riveleranno
fruttuosi e influenti (d'altronte è difficile pensare a una
Nixon In China senza i
precednti di Einstein On The
Beach e Satyagraha...).
La lista dei progetti pensati per il teatro e l'opera è lunga e
qualitativamente dubbia: episodi celebri rimangono Planet
8 (, su testo di Doris
Lessing e prima opera a confrontarsi con il cantato inglese (Satyagraha
era in sanscrito, in Akhenaten
l'inglese era recitato per i recitati), The
Voyage, commissionato per il
cinquecentenario della scoperta dell'America e l'ultima Waiting
For The Barbarians, del
2005, tratta dal romanzo di J.M. Coetzee; a questi lavori vanno
aggiunti quantomeno The
Photographer, ispirata al
fotografo vittoriano Edwerard Muybridge, e la trilogia comprende Orphèe,
La Belle Et La Bete
e Les Enfans Terribles
dedicata a Jean Cocteau.
Non contento della sbornia operistica, Glass negli anni '90 si è
scoperto anche autore di sinfonie. Bisogna però concedergli che i
suoi esordi in questo campo avvengono nel più singolare dei modi: la
sua Symphony No 1
(1992) porta come titolo Low
proprio perchè all'omonimo album di David Bowie si ispira (il
sottotitolo è in effetti "from the music od David Bowie and
Brian Eno"), e musicalmente si tratta di quanto più lontano
esista dalle storiche esecuzioni del periodo minimal. Alle volte
malinconica, alle volte solare, e fondamentalmente piacevole
all'ascolto, la Low Symphony
si situa (giustamente, visti i riferimenti) al confine tra classica e
pop e si condisce di sfumature esplicitamente populista, al punto che
da più parti è stato fatto il nome del solito Aaron Copland. Sempre
iperproduttivo, Glass continuerà a sfornare sinfonie a ripetizione:
al momento siamo arrivati alla numero 8, compresa una Heroes
Symphony ancora dalla ditta
Bowie/Eno (attendiamo a questo punto la Lodger
così che la trilogia berlinese della coppia possa dirsi conclusa).
Il grande pubblico ha però conosciuto Glass non tanto attraverso
opere e sinfonie, quanto grazie all'infinita pletora di colonne sonore
prestate dal compositore al cinema: si va dalla biopic (Mishima
di Paul Schrader, 1985) al Woody Allen più recente (Cassandra's
Dream, 2007), dal dramma al
femminile (The Hours,
2002), a quello storico (Kundun,
1997), dallo steampunk (The
Illusionist, 2006)
all'horror (Candynan,
1992). Il binomio Glass-musica per film trascende lo stesso autore ed
ha imposto praticamente uno standard: quella ammiccante maniera dal
piglio più o meno ripetitivo (alle volte sinfonica, alle volte per
solo piano, ecc) è diventata una lingua franca che sta al cinema
degli ultimi vent'anni come le arie coplandiane stettero al western o
gli stridori atonali stettero all'horror, con la differenza che
arrivati a questo punto nemmeno conta più il genere. Vista la fortuna
dell'espediente, risulta quindi paradossalmente difficile riconoscere
il tocco del compositore in buona parte delle commissioni: spesso
anzi, ci si accorge che le musiche le ha firmate un certo Philip Glass
solo scorrendo i titoli di coda. L'esempio più riuscito resta
probabilmente il famosissimo Koyaanisqatsi
di Godfrey Reggio (1983), sia perchè in questo caso le musiche di
Glass risultano autentiche protagoniste del film (nell'improbabile
ipotesi che non sappiate di cosa si stia parlando, si tratta di un
documentario sulla frenetica civiltà moderna senza dialoghi e senza
parlato), sia perchè l'autore rispolvera un po' del suo afflato più
scontroso per accompagnare, in simbiosi perfetta, le affascinanti
immagini accelerate a tema industriale-metropolitano. L'effetto è
garantito e -figuriamoci- riscuoterà talmente tanto successo da
trasformarsi in ennesimo espediente buono per tutte le stagioni:
ancora oggi, se c'è da descrivere in musica il concitato viavai di un
centro commerciale ripreso nell'ora di punta, niente di meglio che
piazzarci un arpeggio veloce in triplice fortissimo. Così va il
mondo.
Nel 1982, dopo che per anni le sue composizioni furono disponibili o
tramite la propria etichetta privata (la Chatam Square) o in edizioni
limitate, Glass firma un contratto in esclusiva con la CBS Masterorks,
terzo caso della storia dopo quelli di Igor Stravinsky e Aaron Copland:
è il segno che il compositore è salito ufficialmente ai piani alti
dell'establishment musicale, ma ancora più significativo è, in
prospettiva, il lavoro con cui si apre la collaborazione tra
compositore ed etichetta,
Glassworks
non è nè un'opera, nè una sinfonia, nè tantomeno un lavoro per
ensamble come quelli a cui l'uomo di Baltimora si è dedicato per
buona parte dei '70: è invece, a tutti gli effetti, un album pop.
Concepito appositamente per avvicinare alla musica di Glass un
pubblico il più possibile eterogeneo,
Glassworks
può essere considerato tra i primi esempi di musica d'arte midbrow,
buona tanto per gli scaffali degli intenditori colti quanto per le
esigue discografie dell'ascoltatore generalista. I sei brani che
compongono il disco, alternano malinconici "lenti"
(l'iniziale
Opening
sconfina nella new age) a episodi più concitati, memori delle pagine
più aspre del periodo
Einstein On The Beach:
l'album riscuote un successo ragguardevole e rimane, tra le cose della
svolta mainstream, una delle sue prove migliori. La scelta di un
vocabolario semplice, contenuto, distintissimo dalla prosopopea della Akhnaten
coeva, giustifica il ruolo di Glass quale figura-ponte tra mondi
apparentemente inconciliabili quali i residui dello sperimentalismo
anni '70, il populismo postmoderno della nuova opera USA, e le grandi
platee popular. Già in precedenza, ad esempio con le musiche per film
raccolte in North Star
(1977), il compositore di Baltimora era ricorso a un linguaggio
conciso e diretto giusto a un passo dal rock, una sfera che -abbiamo
visto- ricorre sin dai tempi delle prime performance. Naturale quindi
per Glass "passare dall'altra parte": nel 1980 patrocina
l'esordio dei Polyrock, collaborazione che poi (chissà per quale
motivo, visto che l'esito fu ottimo) il compositore ripudierà a più
riprese. Nel 1986 chiama a sè un piccolo manipolo di autori scelti
(David Byrne, Paul Simon, Suzanne Vega, Laurie Anderson) per scrivere
i testi dei brani che compongono Songs
For Liquid Days, disco -non
riuscitissimo- che mette assieme esecutori come il Kronos Quartet da
una parte e Linda Ronstadt dall'altra. E il recente The
Book Of Longing, ciclo di
canzoni su testi di Leonard Cohen, è un apprezzabile tentativo
d'autore che ha saputo conquistare anche ambiti non per forza a
digiuno di arditezze "sperimentali".
Glass in fondo si è crogiolato per anni nel ruolo di mediatore tra
universi reciprocamente sospettosi: è il suo modo di difendersi dai
ripetuti attacchi provenienti da quella parte della critica che non
gli ha perdonato il tradimento del dopo Einstein
On The Beach, o che al
contrario continua a considerarlo un dilettante prestato al mondo
della classica. In generale, tutti i lavori da Satyagraha
in poi suonano accessibili alle orecchie di un pubblico non
necessariamente interessato alle acrobazie d'avanguardia, e questo
indipendentemente dal formato adottato: che si tratti di brani da
cinque minuti circa, o di oere che sconfinano nelle tre ore di durata,
è difficile rimproverargli qualsiasi tipo di ermetismo, o peggio
ancora di inavvicinabile altruista. Quello che gli si può
rimproverare è ovviamente la preoccupante tendenza non solo
alla ripetizione di formule trite, ma anche una disarmante incapacità
di scrivere grande musica da buoni trent'anni a questa parte. Non che,
in una produzione che anno dopo anno si fa sempre più sterminata, non
siano mancati i momenti ispirati, le pagine pregevoli, o anche
semplicemente gli esercizi di stile degni. Ma non si può sorvolare
sul fatto che, pur esistendo le eccezioni, queste si confondono in una
massa di musica spesso e volentieri insulsa, goffa, quando non
leziosamente trionfa. A Glass non si chiede di riesumare
quell'implacabile macchina da guerra che fu il suo ensamble per tutta
la prima metà dei '70: si chiede quantomeno di non sprecare note
inutili -il che, per un uomo che ha già composto più opere di
Wagner, parrebbe una pretesa ormai fuori tempo massimo.
La sua figura resta nondimeno controversa, e i fans si dividono com'è
ovvio da una parte e dall'altra della barricata. Che Glass abbia
costruito la sua fama banalizzando alcune intuizioni degli esordi, o
che al contrario il suo percorso si sia dipanato linearmente in
direzione di una consapevole maggior fruibilità delle opere, è un
dibattito tutt'ora in corso.
Valerio Mattioli
da Blow Up
n° 131 Aprile 2009


|
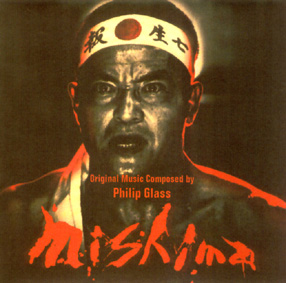 - Mishima
- Mishima
original
motion picture soundtrack
(1985) Elektra 979 113 - vinile
1. Mishima/Opening 2.46 - 2. November 25: Morning 4.08 - 3. 1934: Grandmother And
Kimitake 3.37
- 4.
Temple Of The Golden Pavillon ('like some enormous
music" 3.58 - 5. Osamu's Theme: Kyoko's House 2.58 - 6. 1937: Saint Sebastian 1.05 - 7. Kyoko's House (stage blood is not enough)
5.00 - 8.
November 25: Ichigaya 2.11 - 9. 1957: Award Montage 3.56 - 10. Runaway Horses (poetry written with a
splash of blood) 9.09 - 11. 1962: Body Building 1.29 - 12. November 25: The Last Day 1.30 - 13. F-104: epilogue from Sun And Steel 1.59 - 14. Mishima/Closing 2.57
Musicians:
Kronos Quartet, David Harrington, John Sherba, Hank Dutt,
Joan Jeanrenaus conduceted by Michael Riesman
Produced by Mata Yamamoto and Tom Luddy
Recorded at Green St. Studio, New York and The Living
Room Inc., New York
Engineering by Dan Dryden
Secondo
me, alla lunga, nella lotta spalla a spalla tra David
Byrne e Philip Glass per confezionare il prodotto più
chic, il secondo avrà la meglio, non foss'altro grazie
al mestiere a lungo appreso prima che i fasti minimalisti
lo rendessero giustamente popolare. Che poi quel
"metodo" debba perdere ogni privilegio o
priorità quando si tratta di comporre soundtracks e
vestire azioni da altri immaginate, rassegnandosi ogni
minimalistica esuberanza a comparire solo come una tra le
molte pezze cui ricorrere per confezionare ambientazioni
sonore, tutto ciò fa parte delle rinunce che Glass ha
ormai messo in conto nella personale, dignitosa scalata
al "successo".
Qui egli ricorre a organici orchestrali, diretti dal
fidato Michael Riesman, come in November
25, dall'incedere marziale, o
cameristici (featuring il Kronos Quartet): non sappiamo
se il musicista abbia trovato un corrispettivo delle tre
linee narrative adottate dal regista Schrader certo i
suoni si sforzano di non corrispondere piattamente alla
realizzazione spesso irrealistica e glaciale che molta
critica ha rimproverato al director statunitense. Prevale
uno spirito di "grande musica" romantica, una
compiaciuta e mesta descrizione dell'affondamento di
un'anima capace di evitare nebbie wagneriane per più
asciutti, pur se accorati, climi. Nè mancano episodi
spurii come il tema di Osamu,
dove un complesso beat dialoga civittuolamente con archi,
o Kyoko Hause,
frammento che potrebbe essere sfuggito alla galassia di
una Penguin Cafè Orchestra. Complessivamente, sensazioni
e sapori già noti a chi abbia familiarità con i più
impegnativi Einstein On The Beach
e Satyagrapha dello
stesso autore.
La lezione della grande tradizione europea funge qui da
cane da guardia contro più vili e dissonanti voglie
cageane: emblematico Runaway Horses,
vero manifesto restaurativo dai lussureggianti colori
crepuscolari (ma tutto il film è anatomia di un
tramonto), per tacere dei toni liturgici in F-104.
Jean
Montalbano da Rockerilla n° 65 gennaio 1986
 - The Photographer
- The Photographer
(1983) CBS Records 37849 - vinile
ACT
I 1. A Gentleman’s Honor (vocal) 3.17
ACT II 2. A Gentleman’s Honor (intrumental) 16.25
3. A Gentleman’s Honor (Instrumental) 3.15
ACT II 4. A Gentleman’s Honor (instrumental) 19.17
Musicians:
Conductor: Michael Riesman, Paul Zukofsky, Philip Glass
Jack Kripl, Michael Riesman, Lew Soloff, Ed Carroll, Jim
Pughs, Alan Raph, Bob Carlisle, Ron Sell, Marin Alsop,
Jeanne Ingraham, Carol Pool, Lew Eley, Jill Jaffe,
Maureen Gallagher, Judy Geist, Ted Israel
Adrienne Albert, Betty Baisch, Mary Sue Berry, Rose Marie
Jun
Dora Ohrenstein, Marlene VerPlanck
Produced by Kurt Munkacsi and Philip Glass
Per la
stessa multinazionale che lo scorso anno produsse i
"lavori di vetro" escono ora le musiche per The
Photographer, pièce multimediale
(teatro, concerto, balletto) liberamente ispirata agli
eventi occorsi all'inglese E. Muybridge, pionere della
camera oscura dello scorso secolo, che per motive d'onore
uccise l'amante della moglie venendone assolto,, Sicilia
docet, nel conseguente processo. E se ormai Glass si
permette di scodellare una storiella dell'anno come
qualsiasi rockstar qualche merito dovrà pur averlo
quella CBS di cui l'ex iterativo, passato dai garages di
Villa Borghese ai palchi del Metropolitan, è il secondo
fiore all'occhiello dopo il californiano Riley.
Dell'irresistibile ascesa che lo ha portato dall'audience
settaria delle gallerie alla protezione della signora
bene e di certa nobiltà parassitaria, l'opera in esame
è stazione e tappa di consolidamento dei concensi
conquistati. Dei tre atti che la compongono, il primo
illustra alcuni casi della vita del "gentleman"
con tre numeri musicali uno dei quali, A
Gentleman's Honor, appunto, in doppia
versione, vocale e strumentale, ma con un ensable simile
contemplante, oltre ai familiari organo e flauto, ottoni,
violino e archi. Il tutto sembra confermare l'abbandono
di quella rigidità ed intransigenza minimalistica già
avviato nel monumentale Eistein On The
Beach del 1975, di cui
pure vengono ripresi l'idea di un "processo" e
il ruolo solista del violino (anche qui suonato da Paul
Zukofsky) i cui suoni sostanziano il secondo atto quasi
in forma di concerto. Qui è perfezionato quel lavoro di
piallatura e smussamento là avviato: senza l'affanno di
una teoria da dimostrare o esemplificare, ogni cosa
appare più dolce e levigata in pezzi che non sfilano
più nel nudo scheletro ritmico ma saggiamente vestiti di
colori e timbri come si conviene ad un'opera presentata
in anteprima al Palazzo Reale di Amsterdam.
E' ancora la tastiera a strutturare la musica del terzo
atto, sulla cui cadenza intervengono in successione un
coro femminile e il resto degli strumentisti, archi e
fiati, ma il gioco risulta più che cullante che in
precedenza, tutto riuscendo facile e lieve a chi per anni
ha praticato l'arte impervia di coniugare le ricerche
sulle strutture ritmiche ed armoniche; la musica
glassiana ha smesso la spigolosa severità e la scontrosa
"negatività" delle "due pagine" di
Shandar acquistando quel tono e quella profondità che,
avvolgendola in una quiete classicheggiante, la rendono
meno "estranea": la "cosa glassiana"
è diventata domestica.
Nè vi sono avuti quei sospetti salti all'indietro che
tanto scandalizzavano i catoni dell'avanguardia,
avvenendo tutto per graduale evoluzione, sicchè ad un
ipotetico sguardo complessivo ogni frammento di questa
musica splende di quella doratura che riveste le cose
mature e compiute che nulla chiedono se non d'essere e
risonare.
Jean
Montalbano da Rockerilla n° 33 aprile 1983
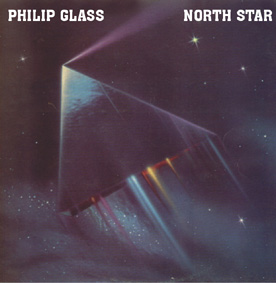 - North Star
- North Star
(1977) Virgin v 2085 - vinile
1. Etoille Polaire (North Star) 2.35 - 2. Victor's Lament 3.35 - 3. River Run 1.50 - 4. Mon Père, Mon Père 3.52 - 5. Are Years What? (for Marianne Moore) 4.00 -
6. Lady
Day 3.57 -
7. Ange
Des Oranges 3.38
- 8. Ave 4.42 - 9. Ik-ook 4.10 - 10. Montage 2.25
Musicians:
Philip Glass, Dickie Landry, Joan Labarbara, Gene Rickard
Produced by Philip Glass and Kurt Munkacsi
Recorded at Big Apple Recording Studios in New York City
Engineering by Kurt Munkacsi and Tom Duffy
Cover by Ed Lee
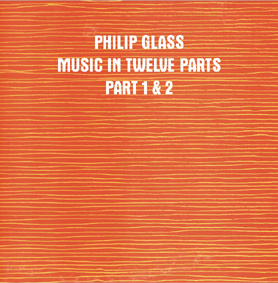 - Music in Twelve Parts
- Music in Twelve Parts
(1974) Virgin v 8049- vinile
1. Part One 20.39 - 2. Part Two 15.16
Musicians:
Philip Glass, Jon Gibson, Dickie Landry, Richard Peck,
Joan Labarbara, Michael Riesman
Produced by Philip Glass and Kurt Munkacsi
Recorded at Big Apple Recording Studios in New York City
Engineering by Kurt Munkacsi and Wieslaw Woszcyk
Cover art by Sol Lewitt
 - Dance Pieces
- Dance Pieces
(1987) CBS fa 39539 - vinile
In The Upper Room
1. Dance I 1.07 - 2. Dance II 5.39 - 3. Dance V 3.20 - 4. Dance VIII 4.55 - 5. Dance IX 8.05
Glasspieces
Glasspieces # 1 ("Rubric") 6.10 -
2.
Glasspieces # 2 ("Facades") 7.16 - 3. Glasspieces # 3 ("Funeral") 8.49
Musicians:
Michael Riesman, Elliot Rosoff, Anahid Ajemian, Sanford
Allen, Mayuki Fukuhara, Jill Jaffe, Carol Pool, Harold
Colleta, Sol Greitzer, Fred Zlotkin, John Beal, William
Rohdin, Wilmer Wise, William Rueckenwald, Joseph Anderer,
Sharon Moe, Robert Carlisle, Dennis Elliot, Alan Ralph,
Robert Smith, Paul Dunkel, Jack Kripl, Jerry Kirkbridge,
Jon Gibson, Richard Peck, Emu Lator, Dora Ohrenstein,
Linda Moss, Lois Martin, Julian Babrber, Al Brown,
Maureen Gallagher, Seymour Barab, John Abramowitz, Larry
Wechsler, Don Christensen
Produced by Kurt Munkacsi
Recorded at The Living Room, New York, and Greene St.
Recording Studio, New York
Engineering by Don Christensen and Kurt Munkacsi
 -
Glassworks
-
Glassworks
(1982) CBS 73630 - vinile
1. Opening 6.18 - 2. Floe 5.32 - 3. Islands 7.39 - 4. Rubric 6.04 - 5. Facades 7.19 - 6. Closing 5.56
Musicians:
Philip Glass, Michael Riesman, Jack Kripl, Jon Gibson,
Richard Peck, Sharon Moe, Larry Wechsler, Linda Moss, Lois Martin,
Julian Barber, Al Brown, Maureen Gallagher, Seymour Barab, John
Abramowits, Fred Zlorkin
Produced by Kurt Munkacsi
Recorded at Green St. Studio, New York
Engineering by Kurt Munkacsi and Michael Riesman
Cover photo by John Paul Endress
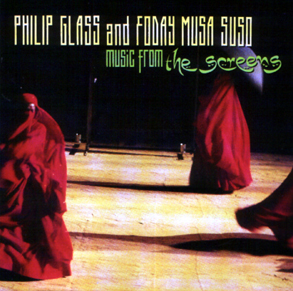 - Music From The Screen
- Music From The Screen
with Foday Musa Sudo
(1992) Point Music 432-966 - cd
1. The Mad Cadi's Court
2.26 - 2. Leila Dies
1.48 - 3. Said And His Shadow Dance
2.49 - 4. Decorating The Dummies
2.19 - 5. Warda's Whorehouse
2.45 - 6. The French Lieutenant Dreams
2.11 - 7. The Arab Women Lament
2.47 - 8. Land Of The Dead
3.26 - 9. Ansatou 2.38 - 10. 19th Century France
1.36 - 11. Said's Treason
3.00 - 12. The Orchard
7.09 - 13. The Village
2.02 - 14. Prison Song
1.15 - 15. Suso's Song
2.39 - 16. France 1.52 - 17. Night On The Balcony
2.02 - 18. North Afrika
4.09
Musicians:
Benjamin Hudson, Michael Parloff, Allen Blustine, Jerry
Grossman, Martin Goldray, Rex Benincasa,
Produced by Kurt Munkacsi
Recorded at Tje Looking Glass Studios, New York City
Engineering by Laura Fried
Cover photo by: Michael Daniel
 -
Heroes Symphony -
Heroes Symphony
(1996) Point Music 454-388 - cd
1. Heroes 5.53 - 2. Abdulmajid 8.53 - 3. Sense Of Doubt
7.20 - 4. Sons Of The Silente Age
8.18 - 5. Neukoin 6.41 - 6. V2 Schneider
6.48
Musicians:
Dennis Russell Davies: conductor
American Composers Orchestra, Vienna Radio Symphony Orchestra and
Stuttgard Chamer Orchestra
Produced by Kurt Munkacsi and Michael Riesman
Photo by Jill Greenberg
Cover design by Frank Olinsky
|